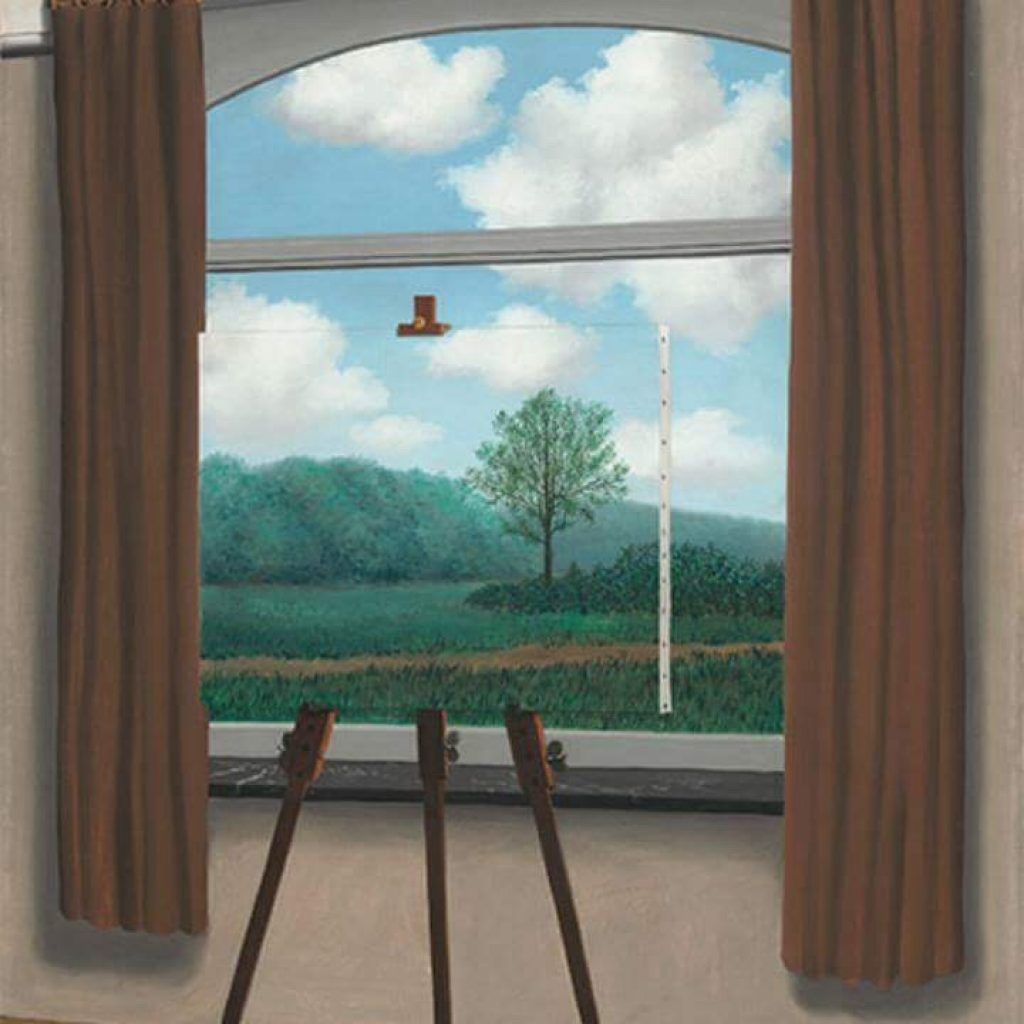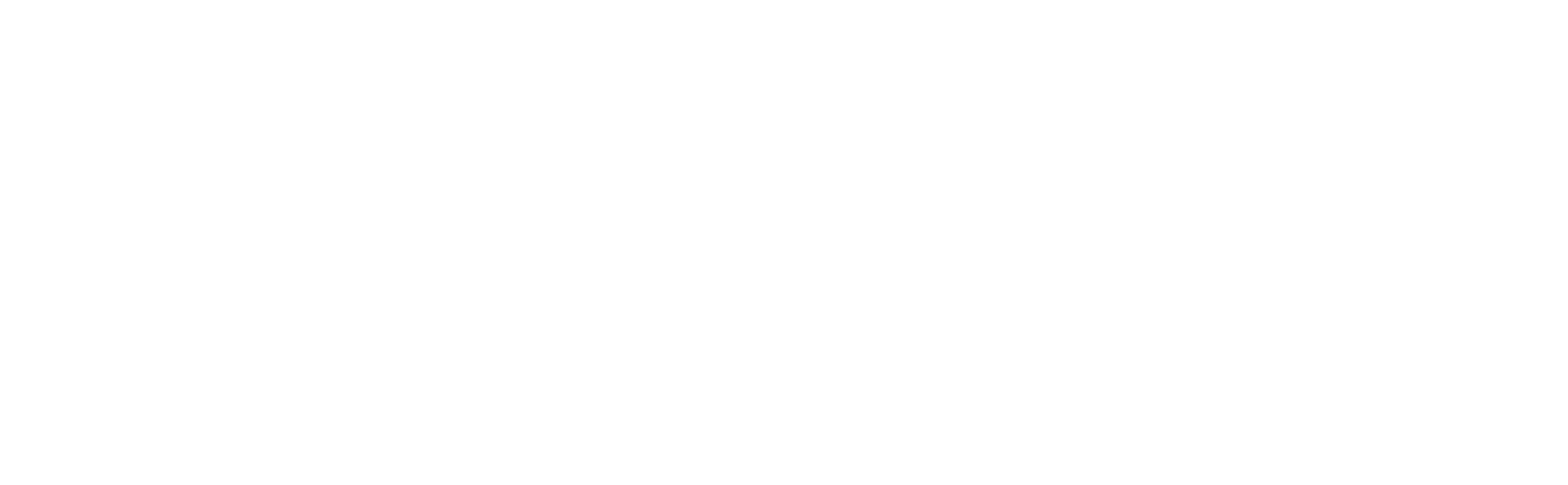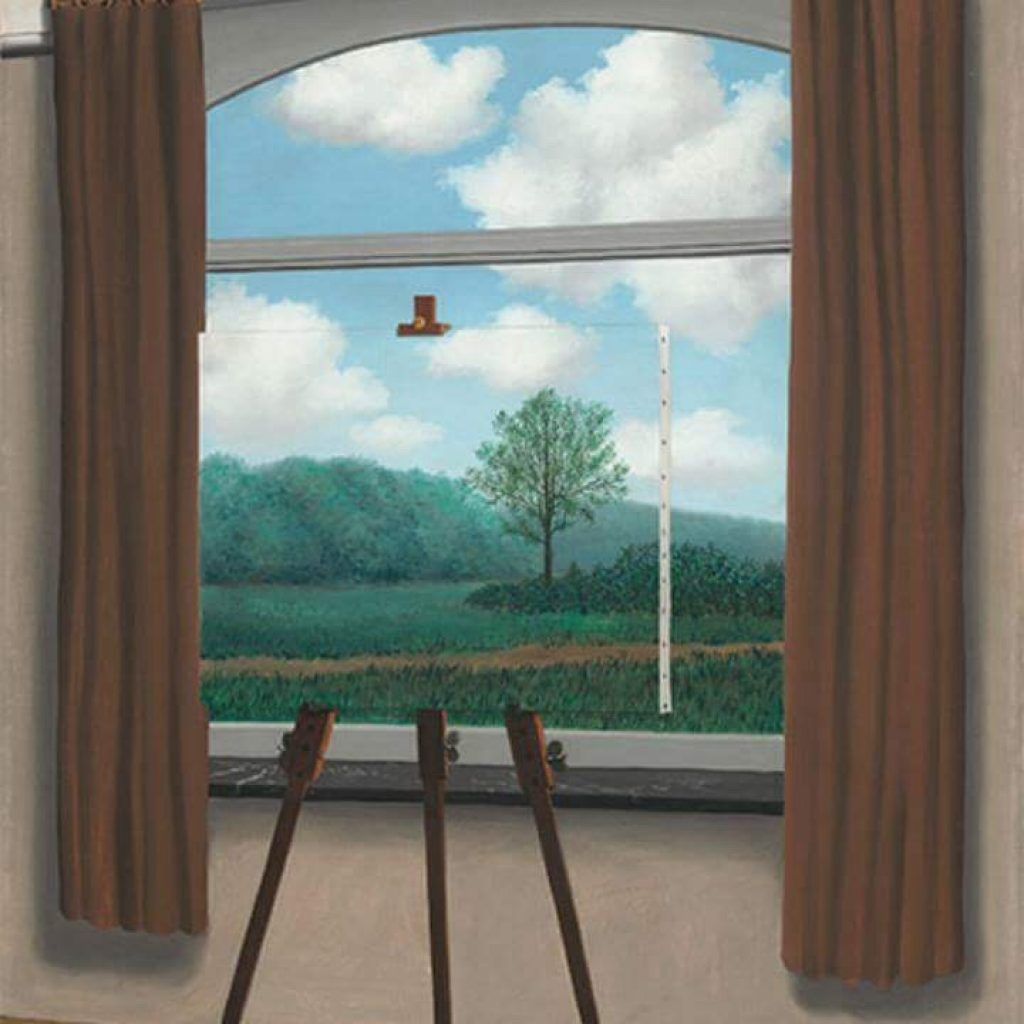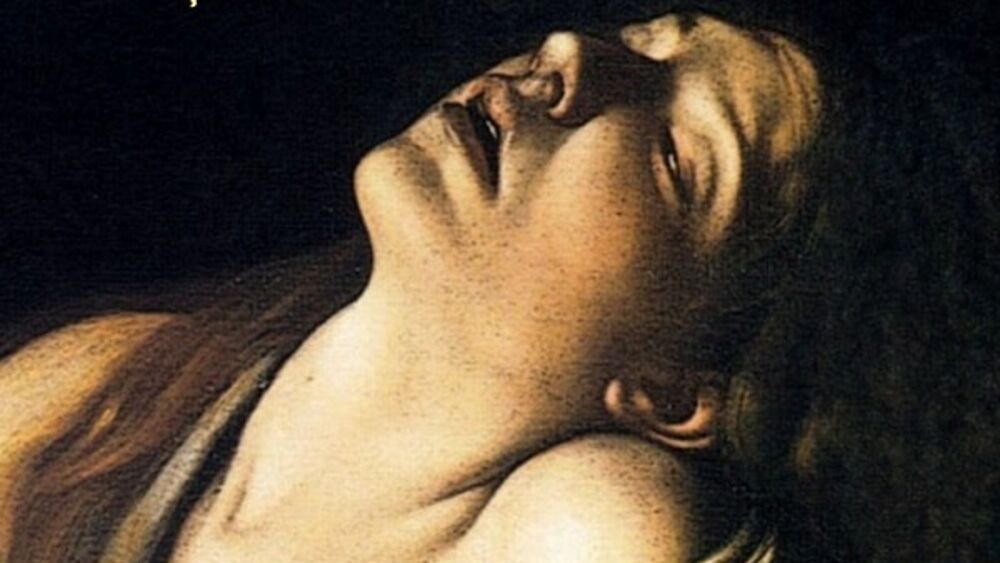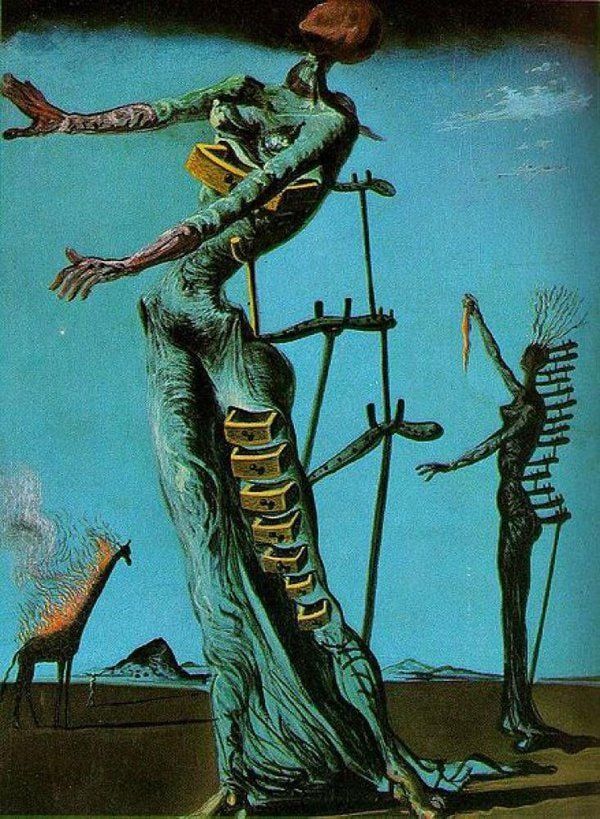Cosa succede oggi alla psicoanalisi?
Cosa è che sta succedendo oggi nel campo dell’insegnamento della psicoanalisi, e forse anche in quello della sua pratica? Prendendo spunto da Miller, sembra che oggi vi sia una tendenza a seguire il modello della religione dei romani del basso impero, e cioè un modello caratterizzato da un sincretismo e da un eclettismo che comportano che, non sapendo a che santo votarsi, si finisca col votarsi a tutti i santi, a tutti gli dei, conosciuti e sconosciuti, per tenerseli buoni tutti e aumentare così il mercato della offerta di “psicoanalisi”, sia a livello del suo insegnamento, sia a livello della sua applicazione alla cura. In conseguenza di ciò sembra si sia arrivati al punto che dovunque ci sia una scuola di formazione che abbia un acronimo che finisca con psicodinamico o psicoanalitico o in qualsiasi stanza si ritrovino a parlare uno psicoterapeuta e un paziente, si stia insegnando psicoanalisi o curando con la psicoanalisi; allo stesso tempo, dentro e fuori di quelle sedi, quel campo definito e individuato come psicoanalisi è sistematicamente attaccato, denigrato, smontato, fino ad essere considerato superato, morto. L’insegnamento e la pratica attuali della psicoanalisi, insomma, piuttosto che muoversi, svilupparsi e anche magari tormentarsi, ma comunque all’interno di quel campo riconosciuto per il fatto di “tenere” un suo assetto di stabile conseguenzialità logica lungo uno sviluppo storico, fatto anche anche di vacillamenti, che attraversa un tempo iniziato cent’anni fa, sembrano sempre più riguardare, invece, una molteplicità di campi, di suggestioni, di innesti e intersezioni che si compenetrano, mutano, si assemblano tra di loro secondo la logica “del vediamo cosa è meglio ora”, in linea con le nuove tendenze filosofiche, culturali, o scientifiche e neuroscientifiche, ma soprattutto secondo quella del mercato della richiesta: “cambio e offro all’istante il mio prodotto, lo adeguo prontamente, alle richieste di mercato del momento”, e siccome il mercato attuale, in obbedienza al discorso del capitalismo post moderno, è quello improntato dalla logica “dell’usa e getta” e “del tutto e subito”, ecco che la nuova psicoanalisi diventa ad hoc psicoanalisi breve, supportata dalle neuroscienze, cui chiede avallo e certificazione di credibilità scientifica. L’inconscio non serve? Sa di antico? E’ superato? Che problema c’è, basta sostituirlo con il neurone, soprattutto con i neuroni a specchio e il gioco è fatto. La psicoanalisi che funziona è quella che serve al momento, e non quella che ha dimostrato la sua efficacia nel tempo. Ecco dunque che, come facevano i romani del basso impero che quando arrivavano da qualche parte si informavano dei culti e degli dei locali e si “mettevano a sgozzare tutto ciò che bisognava perché l’insieme di quegli dei conosciuti e sconosciuti fossero pacificati” così si è pronti a sacrificare l’agnello dell’insegnamento e della pratica ai nuovi, e magari sconosciuti, dei dello scientismo e del mercato del momento. Invece, dobbiamo tenere presente, con Miller, che in questo modo non si fa altro che confondere l’insegnamento, e la pratica della psicoanalisi, con le informazioni, gli apporti e i contributi dei nuovi saperi e delle nuove difficoltà o esigenze di formazione, di apprendimento e di cura.. Insomma piuttosto che allargare progressivamente il campo della psicoanalisi per potervi includere al suo interno tutti i nuovi dei, è bene invece riconsiderare l’utilità di muoversi ancor di più all’interno di quel sapere che si costruisce, e si ricostruisce continuamente, “a partire da un certo numero di presupposti, a partire da un certo numero di assiomi, a partire da un postulato. E poi quel che si deve fare è sperimentare dove porti questo postulato … sapere se tiene, ed è precisamente nell’impasse delle conseguenze di questo postulato, nell’impasse, negli arresti, nelle vaccillazioni delle conseguenze di un postulato, che si hanno delle chance, effettivamente, di verificare di che cosa si tratti. Per questo bisogna provare ad andare fino in fondo nel filo del proprio postulato e se se ne cominciano a trarre parecchie che sono contraddittorie ci si sbarazza del postulato”. Questo il metodo del sapere e della scienza, non quello "usa e getta" del pronto sbarazzarsi del postulato per sostituirlo subito con un altro secondo la logica delle suggestioni dello scientismo e delle sollecitazioni del mercato. Ora chi è che dimostra di andare fino in fondo nel vacillare del postulato da cui parte? lo psicotico. Il cammino della scienza è più prossimo a quello dello psicotico, anche se a differenza di quest’ultimo che del suo delirio non se ne sbarazza mai, il postulato del sapere della scienza, se proprio non funziona la scienza se ne sbarazza. Non è il caso del postulato dell’inconscio. Per questo il cammino di Lacan, il suo insegnamento è così prossimo, così vicino, così intimo a quello dello psicotico. Lacan, come Freud, è andato fino in fondo.