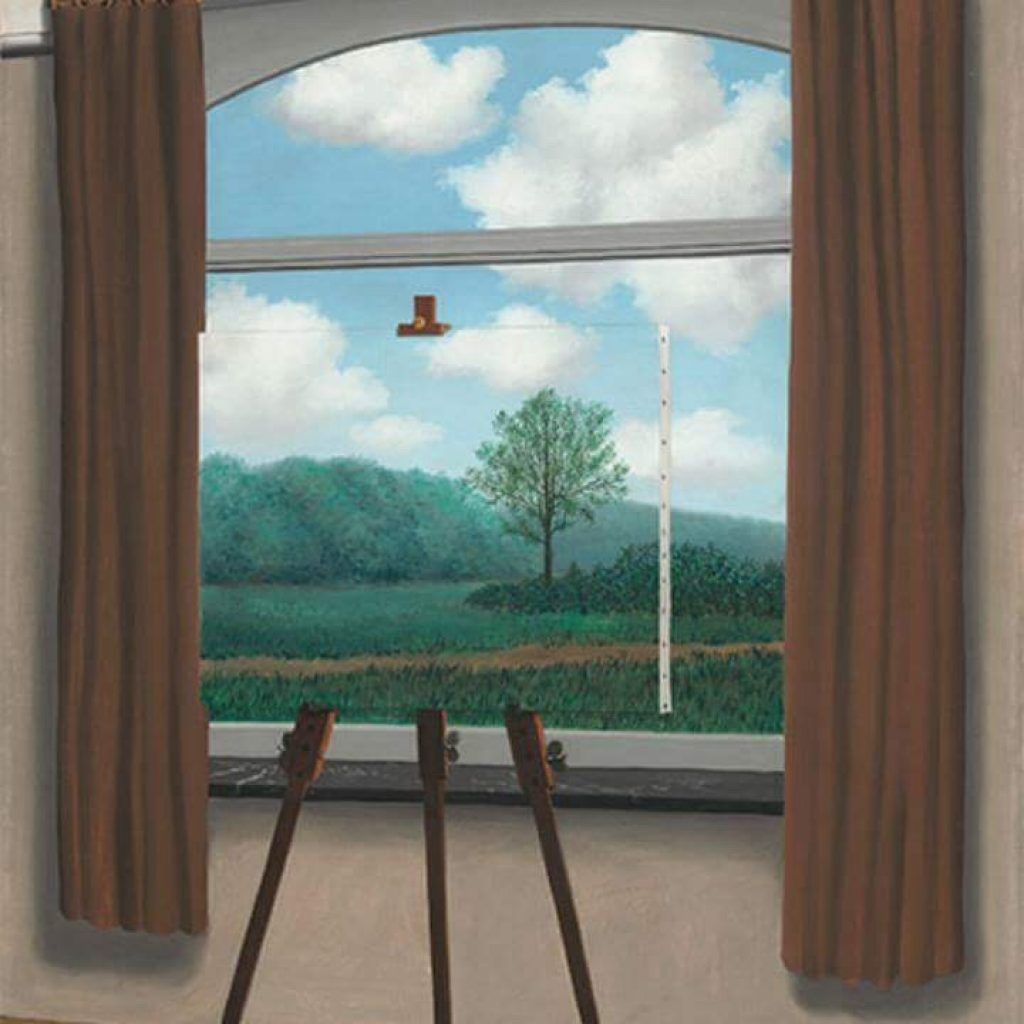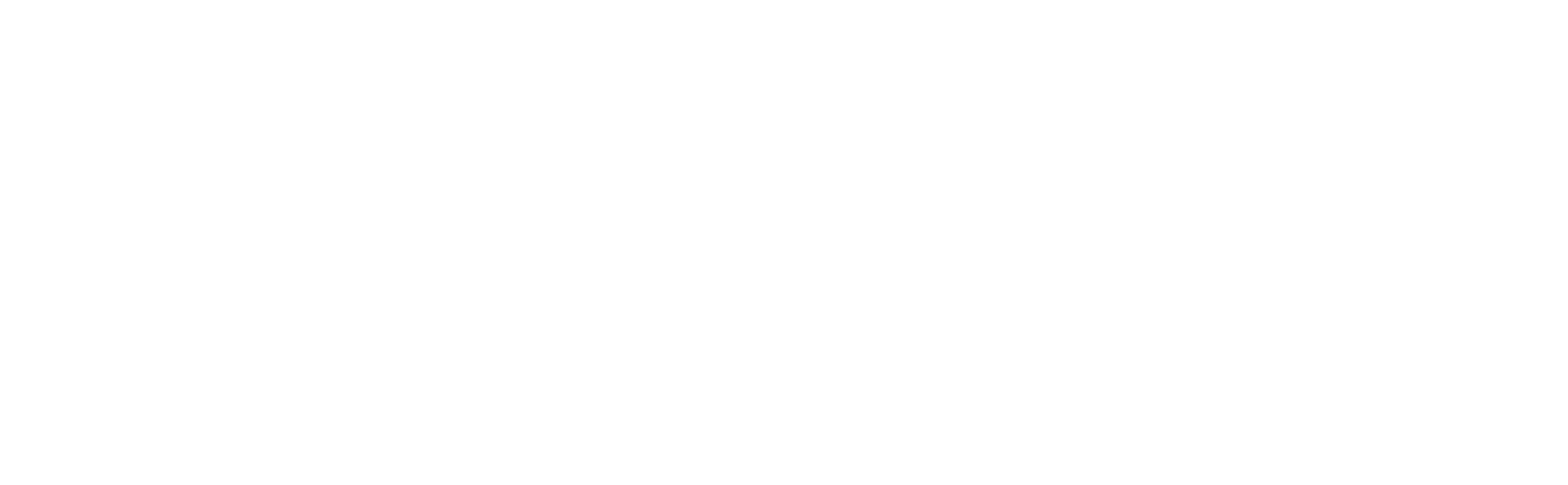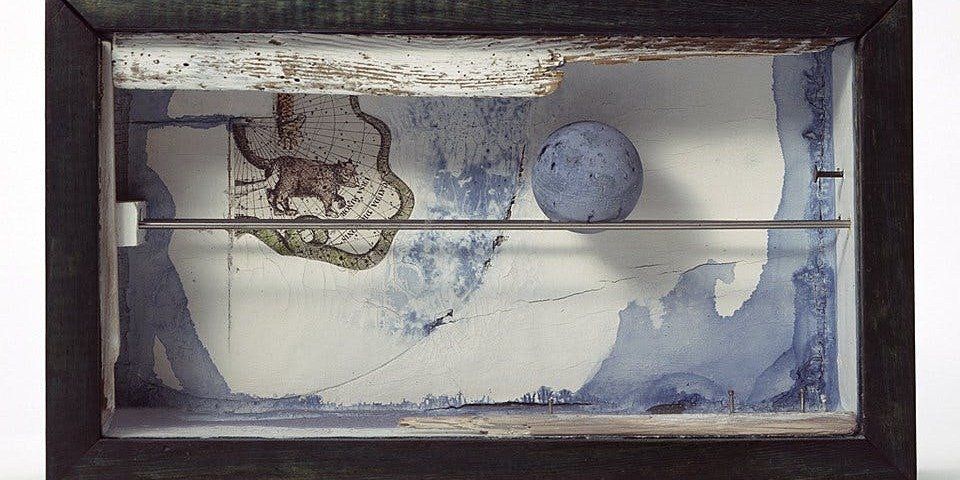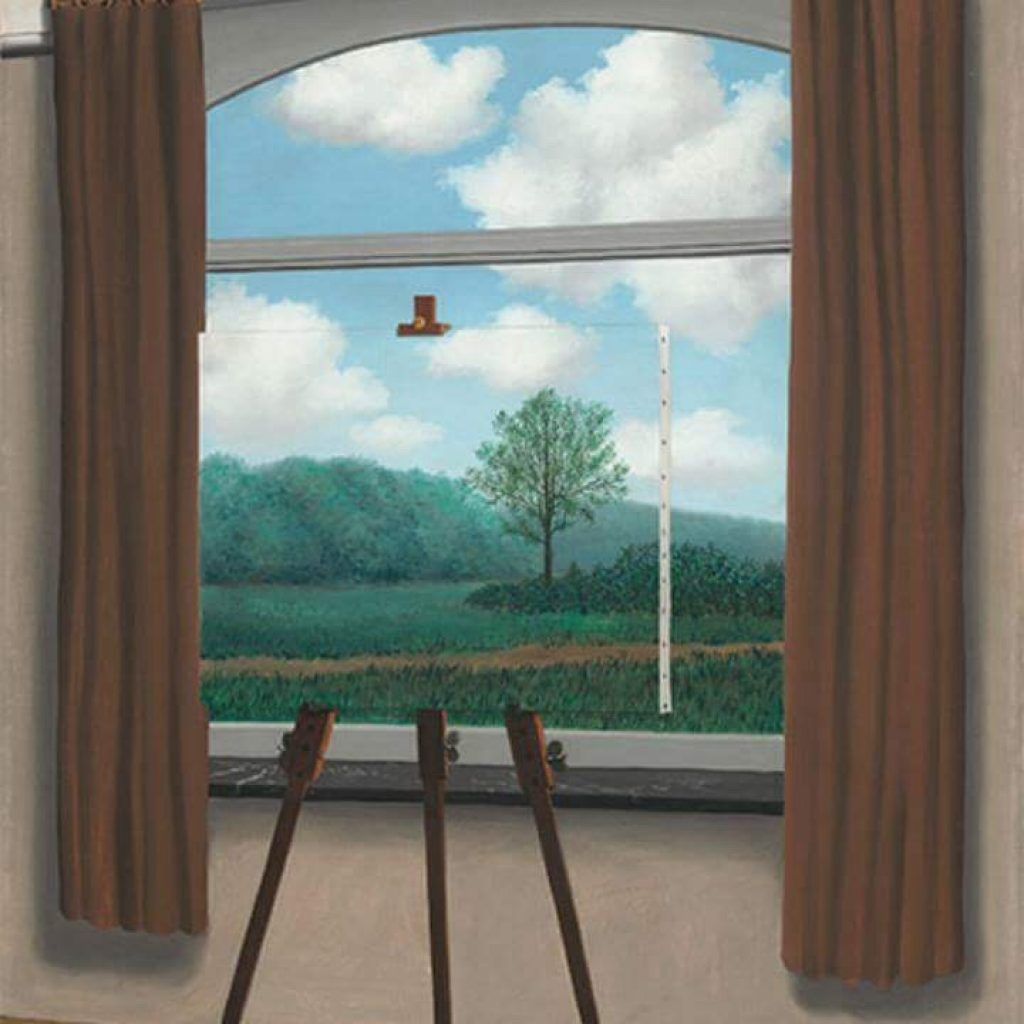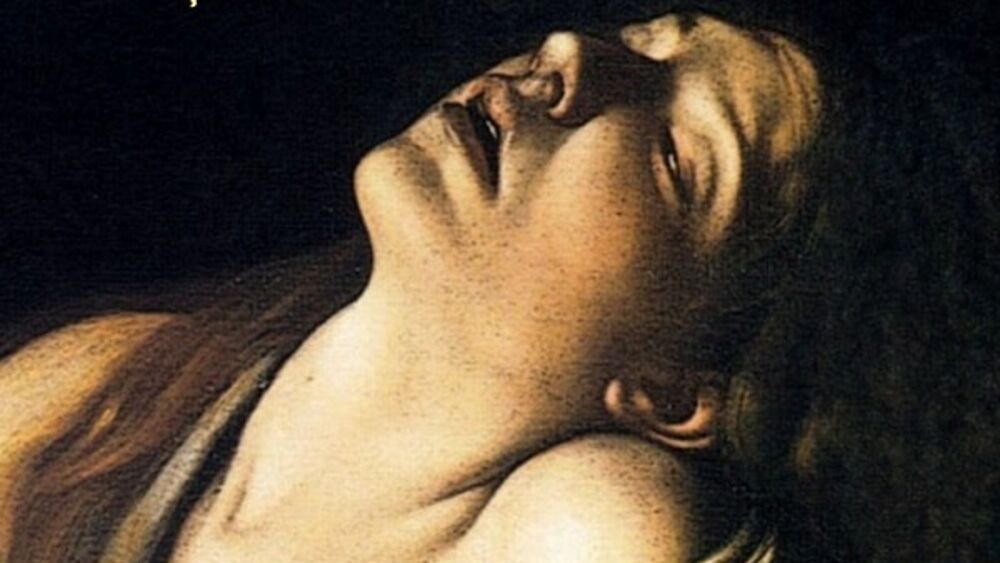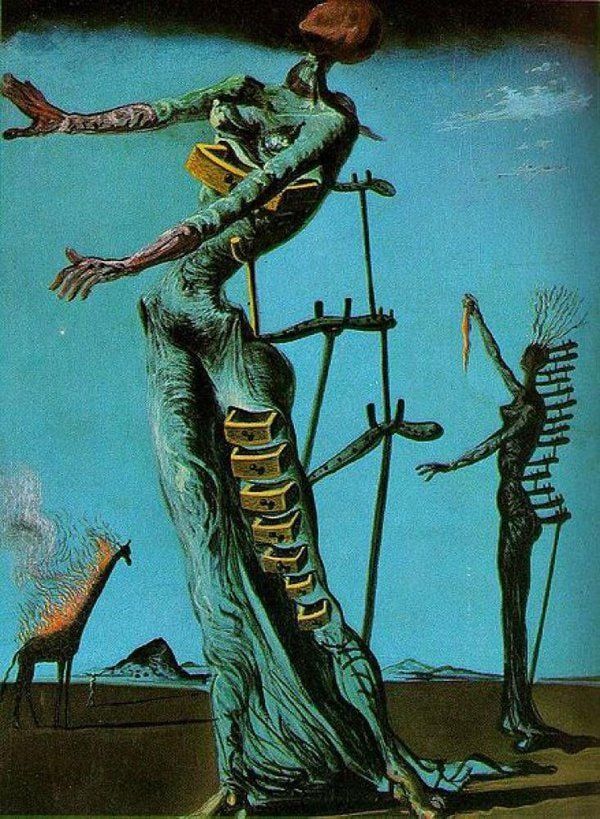L'analista non si autorizza se non da sé stesso
Nuovo paragrafo
La posizione di Lacan sulla cosiddetta formazione degli analisti, su come lo si diventa e in che modo un analista può riconoscersi finalmente come tale, è chiara ed è quella che egli enuncia attraverso la famosa frase: "L’analista non si autorizza se non da se stesso".
Se la posizione di Lacan è chiara, la frase appare però ambigua oppure, come spesso succede con Lacan, enigmatica, controversa, strana. Cosa vuol dire che un analista non si autorizza se non da se stesso? L'interpretazione che ne è stata data, spesso, nella vulgata lacaniana, è che chiunque può autorizzarsi da solo come analista, senza bisogno di alcun riconoscimento da parte di una Scuola, attribuendo in questo modo a Lacan una sorta di disinvolto permissivismo grazie al quale ognuno, se vuole, può ritenersi analista e di conseguenza mettersi a curare pazienti mediante lo strumento della psicoanalisi.
In effetti Lacan vuole dire tutt'altra cosa e, anzi, la sua espressione, se correttamente interpretata, restringe, non amplia, le possibilità -e i rischi - che chiunque possa mettersi a fare l'analista, basti che si "autorizzi da solo".
Innanzitutto, Lacan, come è suo solito fare quando si tratta di enunciare un concetto che deriva la sua forza proprio a partire dalla sua negazione di partenza, pronuncia la frase in una formulazione negativa: dire "l’analista non si autorizza se non da sé stesso" non è la stessa cosa che dire "l'analizza si autorizza da solo", come la frase viene invece abitualmente presentata, e come non andrebbe fatto senza correre il rischio di far dire a Lacan il contrario di quello che voleva dire. La formulazione al negativo, infatti, in maniera particolarmente efficace, e senza ombra di dubbio, rimarca il concetto, non che chiunque possa improvvisarsi analista, ma che chiunque, avendo in mente di voler fare l'analista, per quanto si assicuri un percorso formativo rigoroso presso Scuole per analisti accreditate e, soprattutto, per quanto porti avanti la propria analisi personale fino alle sue estreme conseguenze - condizioni comunque ritenute da Lacan imprescindibili- deve sapere che non potrà autorizzarsi (di qui la necessità di partire dalla formulazione negativa del "non si autorizza") se elude il fatto che riconoscersi analista è un "passaggio" che potrà e dovrà compiere se non da solo: nessuno, né i saggi della Scuola -come avviene nelle Scuole tradizionali per psicoanalisti come quelle dell'IPA- né tanto meno il suo analista potranno dirgli: "ecco ora sei analista!".
In altre parole - vuole evidentemente raccomandare Lacan - il passaggio dalla posizione di analizzante a quella di analista non è un passaggio automatico, né un passaggio che conferisca un "diritto di riconoscimento" scontato, e dunque che possa avvenire per "concessione" dell'Altro della Scuola, di un terzo cioè, ma si tratta di un passaggio che richiede un "atto" di decisione di colui che, avendo compiuto un proprio percorso, si assuma - da solo e "tutto solo" - la responsabilità di dichiararsi analista e di chiedere , per esempio, un "controllo" sulla propria pratica.
Analista dunque non si diventa per nomina, ma attraverso un atto di riconoscimento soggettivo di cui si sappia dare testimonianza, si sappia cioè dimostrare perché si ritiene - a un certo punto della propria analisi - di essere passati dalla posizione di chi parla (analizzante) alla posizione di chi ascolta (analista).
La frase inoltre, accanto al fatto che - come abbiamo visto - non ci si può riconoscere analista se non attraverso un atto in cui si è soli nel momento in cui lo si compie, introduce anche un secondo aspetto, altrettanto fondamentale per il passaggio dalla posizione di analizzante a quella di analista e cioè che un analista è tale non solo se è capace di assumersi, da solo, la responsabilità di richiedere un riconoscimento, ma anche se è capace di "distaccarsi da sé stesso", giacche "non autorizzarsi se non da sé stesso", non significa soltanto "non autorizzarsi se non da solo", ma anche "non autorizzarsi se non prendendo le distanze da sé stesso"
Questo perché, se l'analisi è quel procedimento che avviene solo sotto transfert, e il transfert è, nell'accezione freudiana, "la messa in atto della realtà dell'inconscio", l'analista deve allora essere in grado di permettere che un transfert così inteso si impianti effettivamente, nonché di proteggere l'inconscio del paziente - il suo transfert dunque - da qualsiasi intrusione da parte dell'attualità e della realtà extra-analitiche, compresa quella parte della persona dell'analista che a tale realtà extra-analitica rimane comunque agganciata e dalla quale l'analista deve sapersi, opportunamente, appunto distaccare.
In altre parole, l'analista è quella figura che - chiamata ad implicarsi nell'inconscio del proprio analizzante e a proteggerne il transfert - deve sapersi "distaccare" da quel "se stesso" che invece rimane implicato nella realtà extra-analitica attraverso il proprio personale sistema di valori che, in quanto tali, non devono fare intrusione nel transfert dell'analizzante.
Il che significa che l'analisi in quanto pratica non si dà che nella contingenza di un incontro, quello con il proprio analizzante cui l'analista si dispone attraverso l'atto di non autorizzarsi se non da sé stesso, vale a dire che autorizzarsi come analista è un atto che non vale una volta per sempre, ma che deve essere ogni volta compiuto daccapo, essendo dell'ordine della contingenza - di ciò che ogni volta cessa di non scriversi - e non dell'ordine della necessità - di ciò che non cessa di di scriversi.
In sintesi, dunque, la tanto controversa frase "L’analista non si autorizza se non da se stesso" significa essenzialmente due cose:
1) riconoscersi analista è un atto che si compie da soli, assumendosene tutta la responsabilità;
2) costituirsi come analista è possibile solo se chi vuole lavorare in quanto tale è in grado di distaccare il sé stesso analista - se ce ne è - dal sé stesso persona.