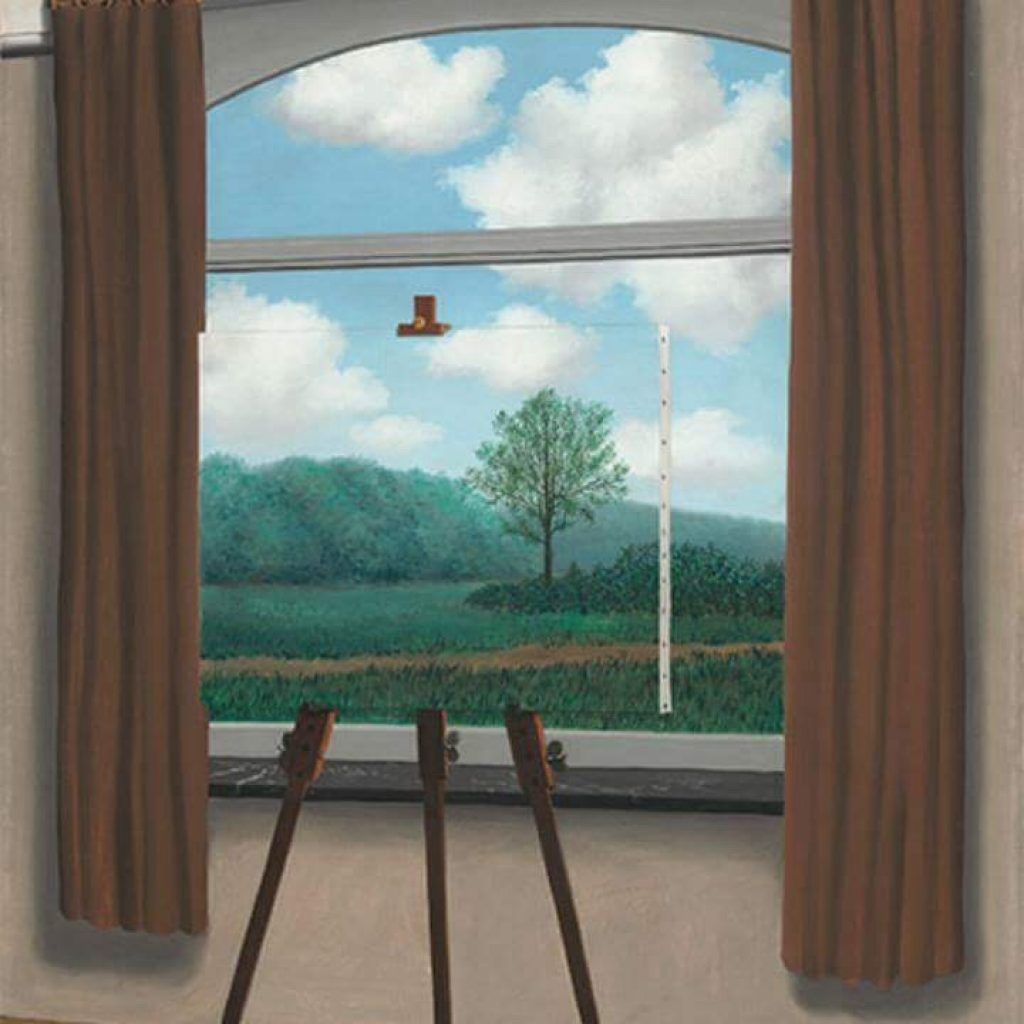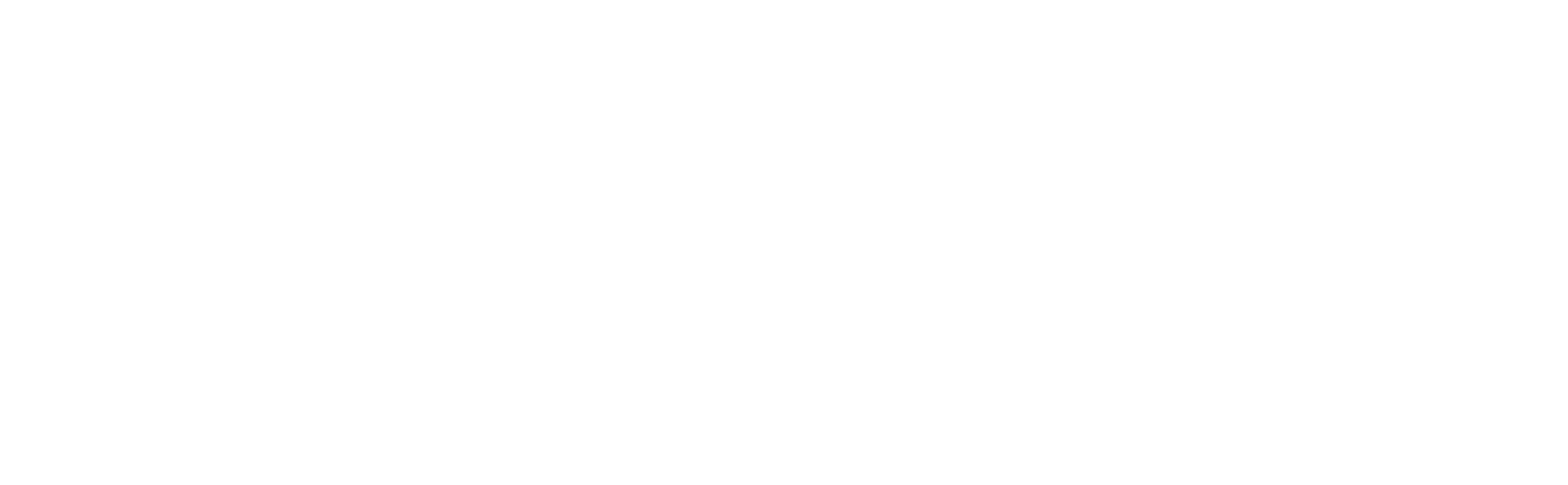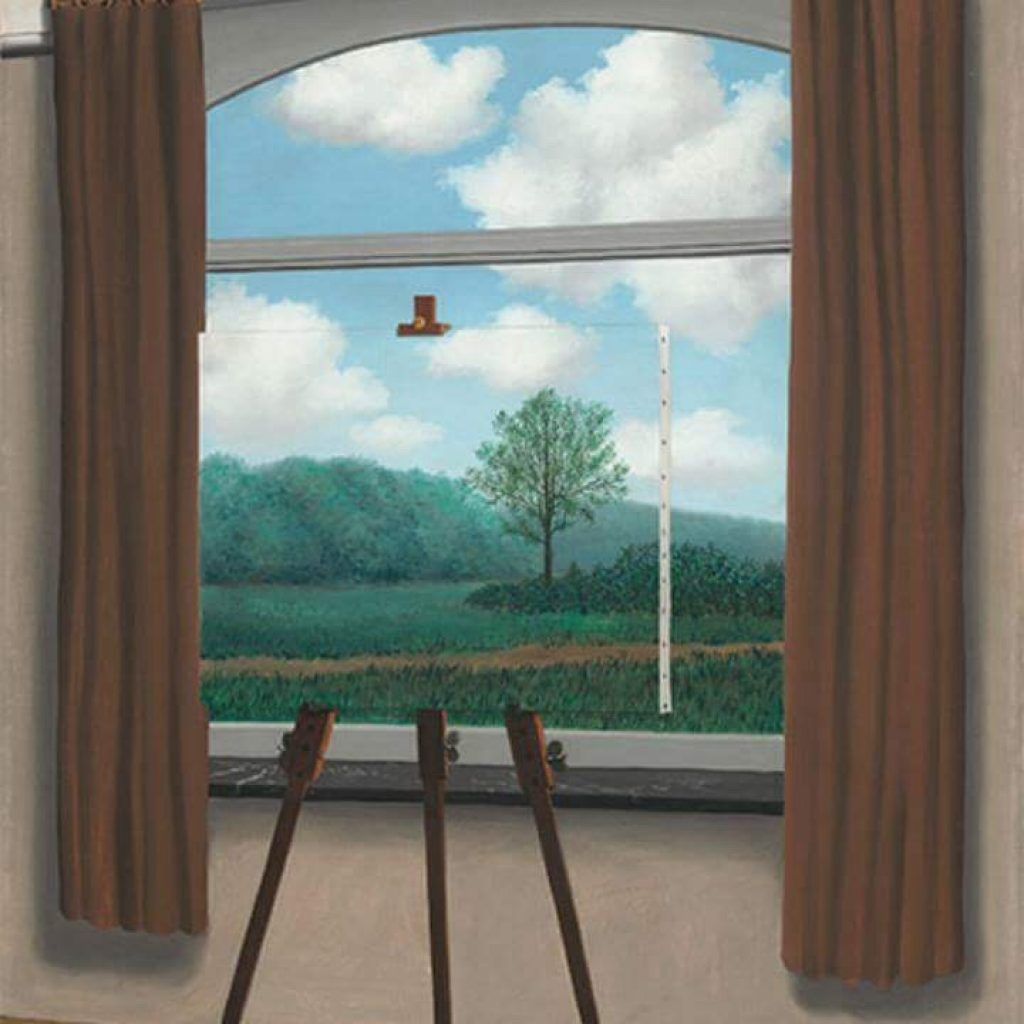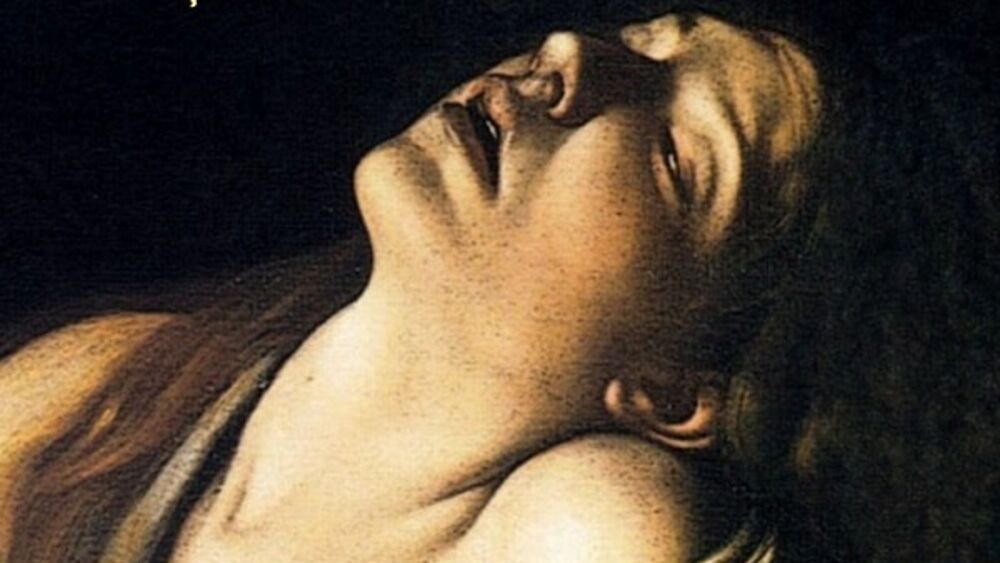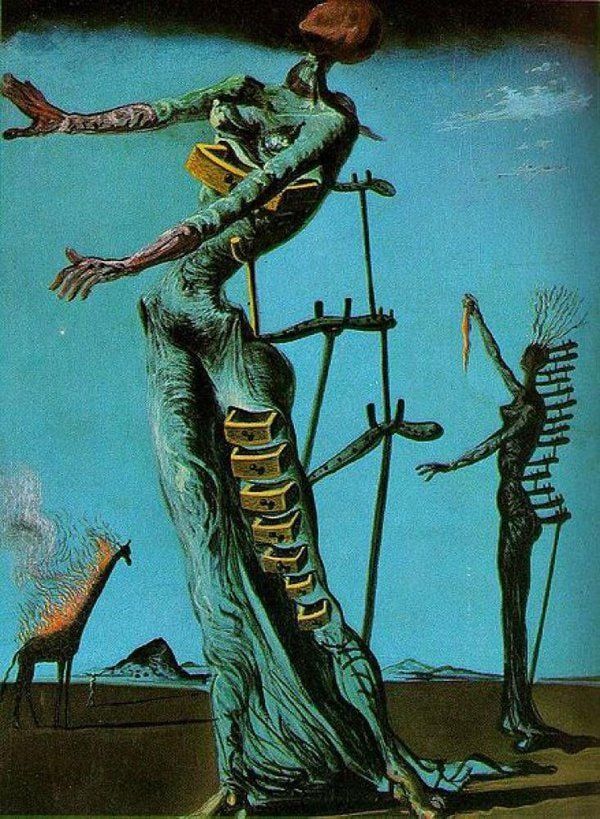PSICOANALISI ORTODOSSA E PSICOANALISI LACANIANA
Il ritorno a Freud
Gli analisti
che, dopo Freud
, pensando di seguirne fedelmente le indicazioni, ma orientandosi in effetti -sulla scia degli sviluppi di Anna Freud
- maggiormente sull' Io
e i suoi meccanismi di difesa
, che sull' inconscio
, -dunque gli psicologi dell'Io prima e i cosiddetti post-freudiani dopo-, sono arrivati di conseguenza anche a ritenere, e con convinzione, che un'analisi possa dirsi effettivamente riuscita solo quando il paziente abbia potuto conseguire quei tre famosi "ideali", che sono ufficialmente considerati gli obiettivi ultimi di un'analisi di successo:
1) l’ideale dell’amore genitale
inteso come quello in cui si realizzerebbe appieno la relazione oggettuale;
2) l’ideale dell’autenticità
, nel senso che essendo quella analitica una tecnica di "smascheramento" non può che condurre il soggetto alla sua autenticità più piena e genuina e alla sua verità senza veli e inganni;
3) l’ideale dell’autonomia
, in virtù del quale il paziente può arrivare alla felice condizione del superamento di qualsiasi vincolo di dipendenza dall'altro.
La psicoanalisi, e la sua pratica tra la maggior parte degli analisti dell'IPA, cominciò dunque a svilupparsi ampiamente lungo questa "idilliaca" direzione, della idealizzazione
dei suoi effetti; fino a quando uno di loro, un certo Jacques Lacan
, acuto psicoanalista francese, non dichiarò coraggiosamente di pensarla in tutt'altro modo, mettendo decisamente in guardia gli analisti dal cedere a queste mire idealizzanti, le quali non potevano fare altro, secondo lui, se non di portare il paziente ad una sorta di ortopedizzazione
idealizzata degli assetti di funzionamento del suo Io. La psicoanalisi freudiana invece consisterebbe, secondo Lacan, nel condurre il paziente a poter piuttosto prendere consapevolezza del proprio desiderio
inconscio, e a saperci fare i conti: sarebbe questo, per Lacan, il vero scopo della psicoanalisi, così come Freud ce l'ha consegnata.
Lacan, infatti, rifacendosi pienamente a Freud cercò di convincere gli analisti che non era l'Io con le sue funzioni, ma il soggetto con il suo desiderio il vero "oggetto" della psicoanalisi, in quanto è da lì, dal suo desiderio rimosso, e "dimenticato", e non dall'Io, che l'essere umano parla e soffre.
Conseguenze di questa "critica" di Lacan alle posizioni in voga tra gli analisti di allora -posizione come abbiamo visto in larga misura a favore del lavoro sull'Io- furono, da una parte, la sua espulsione dalla Società Psicoanalitica Internazionale
, essendo stato egli ritenuto, per le sue critiche, colpevole di " eresia
", e dall'altra, la persistenza ancora più tenace di molti analisti proprio nella direzione contrastata da Lacan, quella della psicoanalisi dell'Io. Una scissione
insomma, dal momento che tuttavia altri analisti, nonostante l'accusa di eresia, apprezzarono e si convinsero alle tesi di Lacan, diventando lacanian
i
, continuando a seguire il suo insegnamento
e dando di fatto vita ad un movimento, quello della psicoanalisi lacaniana
, e della sua Scuola
, oggi a e diffusa e praticata in tutto il mondo.
Ma perché molti degli analisti dell'Internazionale presero, e continuarono, invece la via dell'Io e non quella del desiderio? Perché continuano in questa direzione ancora oggi, e ancor di più, se, come vediamo, possiamo oggi assistere a delle derive
della psicoanalisi, che pur ritenendosi ancora freudiane, si sono spinte fino al limite delle neuroscienze
e del cognitivismo
, fino a quanto cioè di più lontano ci sia da Freud?
Quello che forse diede avvio alla evoluzione della psicoanalisi nella direzione della psicologia dell'Io
e dei suoi sviluppi, fu, a mio avviso, una svista originaria del testo freudiano, svista favorita dalla lettura che ne fece proprio Anna Freud: nel famoso enunciato di Freud " Wo Es war, soll Ich werden
", fu letto un articolo che non c'è perché Freud non lo aveva mai scritto, come invece compare nella traduzione italiana di Musatti
per esempio: " dove era l'Es, l'Io dovrà avvenire
".
Molti psicoanalisti vollero leggere insomma un Das davanti a Ich, e di conseguenza intesero la frase come la raccomandazione di Freud a lavorare sull'Io in quanto apparato "oggettivo", e dunque a lavorare sulle sue funzioni e sull'insieme dei suoi meccanismi di difesa. Cosa questa che li ha portati poi a perfezionare tecniche di addestramento
dell'Io, oltre che a spingere le loro analisi fino al limite delle psicoterapie cognitiviste, e finanche delle cosiddette neuroscienze, e cioè, come è stato detto, fino a quanto di più distante ci possa essere dalla psicoanalisi di Freud.
Lacan si oppose invece energicamente a questa deriva e restituì la frase al suo vero significato: fece notare che Freud non antepose a Ich l'articolo, e dunque che evidentemente Freud non si riferiva a "l'Io" come istanza o come funzione, bensì a "Io" come Soggetto. Non scrisse, Freud: "soll das Ich werden", ma: "soll Ich werden", cioè, traducendo in italiano, non scrisse: "dove era Es deve diventare l'Io", ma scrisse: " dove era l'Es deve giungere Io
". Il che cambia tutta la prospettiva del lavoro analitico: in quanto analisti non dobbiamo lavorare affinché l'Io si sostituisca all'Es, ma affinché il Soggetto arrivi a saper "riconoscere" l'Es, a " soggettivarsi
" cioè sul proprio Es, sulle proprie pulsioni
, in particolare sulla pulsione di morte
, cercando di farci i conti alla men peggio.
Questa allora l'analisi freudiana, la psicoanalisi degli sviluppi freudiani, e non di quelli post-freudiani; questa la psicoanalisi vera e propria: l'analisi del Soggetto e del suo desiderio inconscio, e non quella dell'Io, delle sue funzioni e mirante al suo rafforzamento, in quanto l'analisi che conduce verso la salute
è quella che permette al soggetto che soffre di potersi ricongiungere al proprio desiderio, di soggettivarsi sulle sue angosce
e sui suoi sintomi
, piuttosto che rafforzare un Io ancor più di quanto non lo sia già.
Quella psicoanalisi, dunque, dalla quale le correnti post freudiane si sono sempre più allontanate, e alla quale noi, in quanto analisti che si ispirano a Freud, dobbiamo invece ritornare.